 CHI SIAMO
CHI SIAMO
 ATTIVITA'
ATTIVITA'
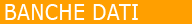 BANCHE DATI
BANCHE DATI
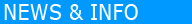 NEWS & INFO
NEWS & INFO
- CIDIM
- Soci
- Musica in rete
- Vincitori di concorsi
- Selezioni e audizioni
- Prime assolute
- Dal vivo in Italia
- Dal vivo nel mondo
- Convegni / Incontri
- Festival e stagioni concertistiche in Italia
- Radio e televisione
- Nuove incisioni, DVD
- Libri e partiture
- Periodici
- Corsi
- Concorsi
- Formazione di base e di nuovo pubblico
- Comunicati e
Rassegna stampa - In Italia e dal mondo
- Festival e stagioni concertistiche nel mondo
 COMMUNITY
COMMUNITY
INTERVISTE
30 aprile 2014: Guido Barbieri dialoga con il teatro musicale di Andrea Molino
Per gentile concessione delle Edizioni Pendragon e del Teatro medesimo, pubblichiamo il testo della riflessione in forma di dialogo condotta da da Guido Barbieri con il compositore. Lo scheletro, la carne, la pelle del tempo, di Guido Barbieri Nel teatro musicale di Andrea Molino si cela, nascosta nelle pieghe dei suoni e delle immagini, una riflessione lucida e pragmatica sulla questione del tempo. Per un verso sull’uso del tempo come materiale compositivo e per l’altro sulla dimensione del tempo nel processo della messa in scena. In un articolo seminale pubblicato nel 1980 Gérard Grisey ha dato forma, in modo quasi epigrammatico, a una essenziale e lapidaria “teoria del tempo” che può essere usata come una lente di ingrandimento per leggere lo statuto temporale, e dunque l’essenza empirica, delle “opere teatrali” (l’espressione è da intendersi in modo risolutamente neutro) di Molino. Come si sa Grisey distingue, in ogni “opera”, tre diversi livelli temporali e attribuisce a ognuno definizioni di carattere “organico”, legate cioè alla fisiologia del corpo umano: lo “scheletro del tempo” rappresenta, per l’autore di Vortex temporum, l’insieme delle regole formali (le divisioni matematiche, le proporzioni razionali, le relazioni tra le parti) che la storia ha sedimentato nella scrittura musicale. La “carne del tempo” è invece costituita dai materiali sonori addensati intorno alla struttura portante dello scheletro: si tratta dei pesi, dei volumi, delle durate, degli spazi del suono. La “pelle del tempo” è, infine, la sottile parete divisoria che separa il tempo della scrittura dal tempo dell’ascolto: è condizionata dalle contingenze in cui si svolge l’esperienza sonora, dall’acustica della sala fino al gesto del direttore d’orchestra, e a tutti i fattori casuali che determinano l’ascolto musicale. Scheletro, carne e pelle corrispondono, a ben vedere, alle tre dimensioni dell’oggetto sonoro, ossia alla sua struttura, alla sua materia (o sostanza) e alla sua forma, viste però sub specie temporalis, colte cioè nell’atto ineluttabile dello svolgersi nel tempo. Ciò implica che l’oggetto sonoro possieda una ineliminabile vettorialità temporale, una necessaria direzionalità, in una parola, una sotterranea o esplicita “narratività”. Nelle opere ultime e penultime di Molino, da CREDO a WINNERS, da Of Flowers And Flames, dedicato al disastro di Bhopal, a Three Mile Island avviene al contrario un fenomeno del tutto originale nel paesaggio del (cosiddetto) teatro musicale contemporaneo. Ossia il rifiuto deciso di ogni forma di narratività esteriore, la sospensione della vettorialità temporale, l’allontanamento, insomma, dalla dimensione lineare e orizzontale del tempo. L’esito, per nulla scontato, è che le tre dimensioni temporali descritte da Grisey vengono inaspettatamente a coincidere: lo scheletro del tempo, privo del sostegno delle strutture del teatro di narrazione, si svuota da ogni condizionamento storico, la carne del tempo non è condizionata da alcuna struttura preesistente e dunque si può manifestare lasciando che i materiali reagiscano imprevedibilmente l’uno rispetto all’altro (il “coro” dell’orchestra, le voci dei testimoni, le relazioni interattive tra il suono e le immagini), nella pelle del tempo, infine, l’ascoltatore/spettatore è libero di inventare la propria dimensione temporale, percorrendo uno o l’altro dei percorsi incisi nella carne, oppure cogliendo l’insieme di tutte le relazioni temporali. Condizione essenziale perché si produca questa “simultaneità” tra gli strati del tempo è per l’appunto la negazione di ogni forma di narratività. “Da quasi quindici anni” spiega Molino, “non c’è mai nei miei lavori una storia di finzione o una storia che voglia essere la rappresentazione o la metafora di qualche altra cosa. Questo tipo di narrazione semplicemente non mi convince più. In - qui non c’è perché -, ad esempio, tutti i personaggi portano i nomi degli interpreti: David Moss è David, i ragazzi dell’Institute for Living Voice sono Aline, Annelinde e Sander. Quando David Moss è in palcoscenico rimane David Moss, anche se la sua voce riporta testi scritti da altri: da Giorgio van Straten, da Shakespeare o da Canetti. Io non chiedo mai al pubblico di esercitare la famosa ‘sospensione del dubbio’ o ‘sospensione dell’incredulità’ come la chiama Coleridge, ossia quella facoltà che consiste nel sospendere le proprie facoltà critiche per godere delle eventuali incongruenze di un’opera di fantasia. Ciò che avviene sul palco è ciò che avviene sul palco: non rimanda, non rinvia a un’altra dimensione. All’inizio dell’opera c’è una lotta, una lotta vera, una lotta fisica, tra due lottatori professionisti, ma noi non vogliamo offrire al pubblico alcun elemento che consenta di attribuire un significato particolare a quella lotta: è un elemento teatrale che deve avere efficacia in se stesso, con la sua energia, con la sua potenza, con la sua capacità di coinvolgimento. Come connettere questa lotta al resto dello spettacolo è compito esclusivo del pubblico. È chiaro che Giorgio van Straten ed io abbiamo voluto dare una direzione concettuale alla rappresentazione. Potremmo dire che con l’aiuto dei testi di Hannah Arendt, di Albert Einstein, di Gitta Sereny e di Primo Levi cerchiamo di riflettere innanzitutto su una delle antitesi classiche del pensiero etico e filosofico: la distinzione tra il Bene e il Male. Intrecciata a questa endiadi forse irrisolvibile c’è un altro passaggio fondamentale, quello che porta dall’individuale al collettivo: Hannah Arendt sostiene, a questo proposito, che noi siamo usciti dalla tragedia della Shoah solo grazie ad alcuni individui che si sono presi sulle spalle un peso immenso, nonostante l’ambiente che li circondava cercasse di ostacolare in ogni modo la loro volontà. E Gitta Sereny aggiunge che sì, è vero, ma la liberazione dalla Shoah è avvenuta solo quando la riflessione personale è diventata un moto collettivo. Da questo deriva il terzo motivo fondamentale della nostra riflessione: ossia il principio della accettazione delle contraddizioni. È un paradigma decisivo del Novecento, una delle grandi svolte epistemologiche del secolo passato. E la dobbiamo ai grandi scienziati europei che cento anni fa hanno rinunciato alla pretesa di descrivere la realtà fisica e hanno sviluppato il concetto di modello: hanno accettato cioè l’idea che ci si può avvicinare alla verità solo per approssimazione e che un modello teorico non è mai perfetto e comunque può essere sempre superato da un altro modello, forse migliore, ma anch’esso fatalmente imperfetto. La conseguenza, se la applichiamo per esempio alla questione dalla quale siamo partiti, ossia la distinzione tra il bene e il male, è che una risposta non esiste. Anzi che la domanda è sbagliata. Se tu mi chiedi come si fa a scegliere tra il bene e il male ti rispondo che non è la domanda giusta. Noi però non vogliamo offrire al pubblico alcun tipo di verità, alcuna tesi rassicurante che faccia uscire dal teatro pacificati e contenti: il massimo risultato che vorremmo ottenere, al contrario, è quello di lasciare al pubblico la strada aperta a ogni tipo di interpretazione”. La decisione di rinunciare a ogni tipo di finzione narrativa ha avuto come conseguenza l’idea, quasi la necessità direi, di portare in scena, nei tuoi progetti passati, fatti, avvenimenti conflitti prodotti (per altro con grande generosità…) dalla storia e dalla cronaca. I temi della pena di morte, delle malattie terminali, dei conflitti etnico-religiosi, dei crimini contro l’ambiente sono stati le nervature scoperte di molti dei tuoi lavori più importanti. In - qui non c’è perché - sembra prendere corpo, da ciò che hai detto fino a questo momento, qualche cosa di diverso: un teatro delle idee, piuttosto che un teatro dei fatti. Qual è dunque, se c’è, il ponte di collegamento tra queste due concezioni teatrali che sembrano, se non in antitesi, per lo meno nettamente distinte? “La continuità per me è completa. Il fatto che io in altri progetti, per altro non in tutti, abbia preso spunto da una serie di fatti legati alla cronaca recente non ha mai comportato la volontà di raccontare quei fatti. Io li ho sempre scelti in ragione della loro assoluta unicità e questo mi ha consentito non di metterli in scena, aspetto per me del tutto irrilevante, bensì di riflettere sulle categorie di pensiero che li hanno generati. Vorrei tornare però al pensiero di Hannah Arendt che riveste una centralità assoluta nella trama concettuale di - qui non c’è perché -. Lei dice: ‘ciò che è accaduto durante la Shoah non ha alcun precedente nella storia dell’umanità. E quindi certe categorie di pensiero erano del tutto impensabili prima della soluzione finale e delle sue spaventose conseguenze’. Lo stesso discorso vale ad esempio per il disastro di Bhopal. Un incidente come questo poteva accadere soltanto in quel momento storico perché lo sviluppo della tecnologia non consentiva di impedirlo. Ma il fatto che sia accaduto ha completamente cambiato la percezione del pericolo ambientale. - qui non c’è perché - non si colloca in alcun momento storico particolare, anche se l’esperienza della Shoah possiede naturalmente una centralità innegabile. Il nostro sguardo è più ampio e va a toccare alcuni temi estremi che hanno provocato e forse continuano a provocare un cambio di paradigma del pensiero dominante. Non è un caso, ad esempio, che una delle scene centrali dell’opera sia dedicata al tema delle madri assassine. L’uccisione dei propri figli è la contraddizione più estrema, più indicibile di cui si possa avere esperienza. E dal momento in cui la società ne ha preso atto, se non coscienza, molti dei valori dominati sono necessariamente mutati”. Il rifiuto della finzione narrativa comporta anche un’altra conseguenza rilevante, credo, sul piano della drammaturgia, ossia la centralità assoluta del criterio di necessità. La componente testuale dei tuoi spettacoli contiene sempre un rispetto assoluto dei dati di verità. Nomi, luoghi, dati, eventi, fatti devono sempre rispettare scrupolosamente ciò che è accaduto. Niente deve e può essere inventato. Come si coniuga il criterio di necessità nelle scelte testuali che avete compiuto insieme a Giorgio van Straten? “Il criterio di necessità consiste, in - qui non c’è perché -, nel rifiuto di attribuire agli interpreti qualsiasi tipo di ruolo. Questo è anche uno dei motivi per cui lo spettacolo presenta una fortissima componente non testuale, nonché una diffusa presenza di elementi vocali, ma non testuali e dunque non semantici. Infatti, quando con Giorgio abbiamo dovuto stilare il libretto dell’opera ci siamo trovati in grande imbarazzo. Il libretto di - qui non c’è perché - è di fatto un collage di testi eterogenei e non è assolutamente sufficiente a dare una idea precisa e compiuta della drammaturgia dello spettacolo”. Il tuo teatro musicale non prevede mai la presenza di personaggi, ossia di caratteri e di ruoli tradizionalmente definiti come tali. Una delle conseguenze, mi sembra, è quella che la drammaturgia sia spesso affidata a elementi di carattere corale, a moltitudini di volti, di voci, di parole, alla molteplicità, insomma, piuttosto che all’unicità dei caratteri. Accade così anche in - qui non c’è perché -? “L’utilizzo della molteplicità, prima ancora della coralità, è un elemento estetico per me assolutamente fondamentale. Questo è il motivo per il quale io ormai lavoro quasi esclusivamente con grandi organici. L’orchestra sinfonica, ad esempio, è per me un organismo composto da una miriade di frammenti, di piccoli eventi sonori che devono essere sempre ricomposti per realizzare un discorso musicale compiuto. Lo stesso criterio vale anche per il versante visivo dello spettacolo. Nella scena finale compare, ad esempio, sullo schermo un vero e proprio sciame di volti e parole. Una miriade di uomini e donne, una collettività di individui, che cercano riposta alle domande raccolte durante la rappresentazione: un grande coro, appunto, cantato da una molteplicità di voci diverse. E questa propensione verso la molteplicità è strettamente collegata a uno dei motivi fondamentali dello spettacolo, ossia, come dicevo prima, il passaggio dall’individualità alla collettività”. A proposito di domande e di risposte. Il titolo dell’opera, - qui non c’è perché -, rimanda esplicitamente a un passo di Se questo è un uomo, in cui Primo Levi sembra in realtà escludere la possibilità non solo di una risposta, ma anche di una qualsiasi domanda. In particolare della domanda cruciale sul perché, sul perché della Shoah. Forse vale la pena riportare integralmente le parole di Levi: “Spinto dalla sete, ho adocchiato, fuori di una finestra, un bel ghiacciolo a portata di mano. Ho aperto la finestra, ho staccato il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti uno grande e grosso che si aggirava là fuori, e me lo ha strappato brutalmente. – Warum? – gli ho chiesto nel mio povero tedesco. – Hier ist kein Warum – (qui non c’è perché), mi ha risposto, ricacciandomi dentro con uno spintone”. In che modo, nella drammaturgia dello spettacolo si passa dalla negazione di qualsiasi domanda alla individuazione di una possibile risposta? “È vero, Primo Levi sembra negare la possibilità di una qualsiasi spiegazione logica della Shoah. In Sommersi e salvati dice, come si sa, che non sono stati certo i migliori a salvarsi, che non c’era alcun criterio di distinzione tra la condanna e la salvezza. Però Levi dice anche un’altra cosa in Se questo è un uomo. È un passo bellissimo che avrei voluto utilizzare nel testo, ma non l’ho fatto: ‘Durante la prigionia noi eravamo straordinariamente attenti ad ogni segno, anche il più apparentemente insignificante, che interrompesse la normalità della vita quotidiana. Non potevamo sopportare la totale mancanza di significato di ciò che ci stava accadendo e anche il minimo segnale di interruzione della normalità assumeva per noi un significato immenso, incalcolabile’. Ed ecco che ritorna, sulla eco di queste parole, la mia scelta del rifiuto delle metafore. Il rifiuto delle metafore è una scelta dolorosissima, anche violenta, in un certo senso. Se c’è qualche cosa che la Shoah ci ha insegnato è proprio che non c’è un perché. E soltanto rendendosi conto che non c’è un perché, rinunciando al desiderio di creare i perché, è possibile trovare una strada completamente diversa per affrontare la dimensione del dolore, della sofferenza, della innegabilità delle contraddizioni. Ma non è detto che questa sia la parola ultima, la parola definitiva. Nel finale dello spettacolo David Moss cita la famosa ‘sentenza’ conclusiva del Macbeth di Shakespeare: ‘La vita non è che un’ombra che cammina (…), una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa nulla’. Ma subito dopo aggiunge, e questa è una bellissima invenzione di Giorgio van Straten: ‘non significa nulla, ma è qualcosa’. E insiste: ‘Qui non c’è perché, ma noi siamo qui’. Ecco questo è forse il nucleo profondo della nostra riflessione. E mentre lo dico mi viene la pelle d’oca: l’esistenza va al di là di ogni riflessione sul perché. Il riconoscimento del fatto che un perché non esiste può portare e ha portato, forse deve portare, alla disperazione, alla desolazione. Però l’esistenza è un dato di fatto. Non c’è un perché, ma noi siamo qui. Non è una descrizione, non è una presa di posizione, è una realtà. È la pura esistenza ad essere decisiva”. La tua risposta conferma una ipotesi che in un certo senso si era già affacciata all’inizio della nostra conversazione: se il tuo non è un teatro di metafore non può essere nemmeno un teatro di simboli. Però è un teatro di segni, quei segni che Primo Levi cerca in ogni cosa che accade all’interno del campo di sterminio. Perché il segno – a differenza del simbolo che rimanda sempre a qualche cosa di diverso da sé – possiede la concretezza, la fisicità di un elemento materiale, presente, visibile. Insomma è la carne del tempo, per tornare alle riflessioni iniziali di Grisey, che si stacca dallo scheletro delle norme e delle convenzioni e che si offre alla pelle del tempo, allo sguardo dello spettatore che vede incise nella propria pelle le stimmate dell’esistenza. Oltre ogni perché. Per gentile concessione di Edizioni Pendragon e Teatro Comunale di Bologna.
|







